Eileen Southern – La musica dei neri americani
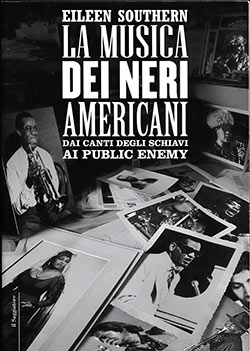
Dopo trentasei anni dalla prima pubblicazione e dieci dall’ultima edizione, nel 2007 è arrivato in Italia questo testo del 1971 diventato pietra miliare nella saggistica sulla musica afroamericana perché ampliò il racconto della complessa vicenda umana e musicale che, soprattutto dagli anni Sessanta del secolo scorso, aveva visto fiorire decine di pubblicazioni trattanti l’argomento in modo parziale e limitato al ventesimo secolo.
Eileen Southern fu la prima a narrare in un unico volume la storia della musica dei neri in America a partire dal 1619, quando una nave olandese da guerra carica di africani sbarcò nella colonia inglese di Jamestown, sulla costa nord-orientale americana.
Diviso in quattro dense parti attraversanti a suon di musica quattro secoli di storia americana, ha richiesto anni di lavoro e varie stesure. Non di facile lettura a causa del taglio enciclopedico, è di sicuro arricchimento per espandere la visione calandosi, per forza di cose non sempre in modo approfondito, in un vastissimo universo che va dalla musica popolare a quella colta. Naturalmente, queste due grandi tipologie raccolgono molteplici espressioni, ognuna delle quali in un modo o nell’altro ha ottenuto risonanza e rilievo internazionale, oltre che agire profondamente sullo sviluppo della musica americana, e di conseguenza della musica europea del Novecento.
Se così non fosse, non se ne sarebbe trovata quasi traccia se non dall’inizio delle registrazioni, e non se ne continuerebbe a parlare ancora oggi. La quantità e la qualità della produzione afroamericana è un fenomeno unico non riscontrabile in altri contesti, con un’«alta densità musicale, che uno studioso moderno ha definito come una profusione di attività musicali che procedono simultaneamente all’interno di uno spazio relativamente piccolo».
Il resoconto si snoda dalla musica degli schiavi, in ambito lavorativo come in quello ricreativo e religioso (quest’ultimo esaminato in modo rigoroso e con le differenze tra le varie denominazioni), passando per la musica delle bande militari, da parata e orchestrale, dal minstrelsy e il vaudeville alla nascita del blues e del jazz, dallo sviluppo della musica classica nei teatri (corale, opera, concerto, musical), nelle università e nelle varie istituzioni, fino alla produzione per il cinema e la radio, procedendo nel tempo non per genere, e quindi seguendo a più riprese l’evoluzione di questa o quella forma.
Dall’età coloniale fino ai nostri giorni, Southern accompagna in un viaggio in cui è data importanza al panorama storico e sociale, soprattutto urbano, e nell’evidenziare le prime affermazioni e innovazioni degli artisti neri, senza tralasciare le donne che brillarono anche in campi solitamente riservati agli uomini (come direzione d’orchestra e composizione), e la nascita di associazioni, organizzazioni, congregazioni, conservatori, istituzioni o altro, legate a personaggi di rilievo e focolai che hanno nutrito la cultura afroamericana sotto vari aspetti.
C’è più racconto dello sviluppo della musica colta che di quella popolare, e più di quella dell’area nord est degli Stati Uniti rispetto al sud o all’ovest, in parte attribuibile alla mancanza di fonti che possano documentare un’attività ricca ma difficile da rilevare quando avvenuta al di fuori da ambiti istituzionali, religiosi, societari, teatrali, anche per le diverse condizioni di vita e di percorso educativo tra neri del nord e del sud. Sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale anche la propensione dell’autrice afroamericana che, oltre a occuparsi di musicologia, ricerca e insegnamento, si formò come pianista classica, ma è altrettanto evidente che si nutrì anche di cultura popolare arrivando a possedere un bagaglio musicale prezioso.
Il primo capitolo riassume l’eredità africana, affidandosi a testimonianze importanti riportate da vari mercanti, da Olaudah Equiano, uno dei primi africani ad aver scritto un libro in inglese, e da T.E. Bowdich, musicista, pittore e scienziato, il quale tramite disegni e trascrizioni di melodie diede un contributo notevole in un’epoca in cui la deportazione era in corso.
Oltre alla descrizione di strumenti e di occasioni musicali, si trovano riferimenti a caratteristiche riscontrabili anche negli schiavi d’America come nei musicisti del Novecento, ad esempio lo stile vocale, l’elemento metronomico, (1) l’improvvisazione, la pratica antifonale. Il linguaggio riportato da Bowdich poi, con figure retoriche “iperboliche e pittoresche”, si ricollega a ciò che si legge in Slave Songs a proposito dell’utilizzo di descrizioni colorite e fuori dal comune in risposta a domande semplici o quotidiane, mediante l’uso della parola per immagini.
Qui abbiamo esempi attribuiti agli accra, che per “buonanotte” dicevano “dormi fino a che il mondo si illumina” oppure, celebrando l’anno nuovo, “i punti estremi dell’anno si sono incontrati”. È facile dunque immaginare quanto una visione della vita così poetica e suggestiva possa essersi sublimata, a contatto con le dure condizioni trovate nel Nuovo Mondo, nell’astrazione e nella carica emotiva dei canti degli schiavi prima e del blues poi. Nelle danze, i testimoni europei osservarono la disposizione circolare, la limitazione del movimento della testa e del busto, e l’uso di un passo strascicato, equivalente alla descrizione del ring-shout praticato dagli schiavi (e non) durante le riunioni di preghiera.
Accurato per quanto possibile è il racconto di come si sviluppò la musica nelle colonie, con grandi differenze tra nord e sud, in particolare lo sono le descrizioni riguardanti il canto religioso, dalla prima forma della salmodia con il lining-out, in cui i compiti del maestro erano d’intonare il salmo per i fedeli avviando la melodia, cantando forte e chiaro in modo che la comunità potesse seguirlo, fino allo sviluppo dell’innodia, diventata un’esigenza, la nascita dello spiritual e l’entrata della musica e degli strumenti in chiesa, arrivando fino al gospel moderno.
Nei secoli furono molte le tappe nell’evoluzione della musica popolare e religiosa afroamericana (la culla del blues), ma fondamentali furono i movimenti del Great Awakening e personaggi come il ministro inglese Isaac Watts, il quale pubblicò un libro, Hymns and Spiritual Songs (1707), che riscosse molto successo nelle colonie e in special modo tra i neri, (2) grazie alla freschezza e alla vitalità dei testi. I fedeli iniziarono a preferire gli inni ai salmi, musicati con melodie più vivaci, e una dopo l’altra le diverse denominazioni protestanti adottarono questi inni, iniziando la cosiddetta “era di Watts”.
Non meno importanti furono i Wesley, padre e due fratelli, fondatori della chiesa metodista nel 1729, con l’innario di John Wesley fondamentale nella diffusione dell’innodia, influenzando indirettamente lo sviluppo dell’innodia nera. Come spesso accade, per i fratelli Wesley la suggestione e l’ispirazione giunsero per caso, nell’incontro con la musica di un gruppo di moravi d’origine tedesca a bordo della stessa nave verso le colonie nel 1735, i cui inni suscitarono profonda commozione nei due. Si nota inoltre come fra i gruppi religiosi più interessati alle condizioni della popolazione nera c’erano innanzitutto i quaccheri, poi i moravi, in qualche misura i congregazionalisti, i cattolici e, a partire dal tardo Settecento, i metodisti.
Dietro la nascita delle prime congregazioni nere indipendenti e dei movimenti separatisti si distinse il reverendo ex-schiavo Richard Allen, fondatore della prima chiesa AME e autore di innari di successo a partire dalla prima raccolta di inni selezionati tra i preferiti degli schiavi, per la maggior parte di Watts, dei fratelli Wesley, e qualcuno forse anche suo.
Fu di fondamentale importanza nell’evoluzione della musica afroamericana la nascita dello spiritual, la cui diffusione al di fuori del suo ambiente naturale, a livello nazionale ed europeo, cominciò nella seconda metà dell’Ottocento esclusivamente allo scopo di raccogliere fondi per le istituzioni, con i concerti e le tournée di un gruppo di studenti della neonata Fisk University di Nashville diretti da George L. White, professore bianco che fornì una formazione musicale approfondita agli studenti più promettenti e, soprattutto, oltre alla musica classica, lasciò che s’esprimessero anche nella “loro musica”. Inoltre, per il consolidamento e lo sviluppo della tradizione popolare fu importante la pratica del ring-shout nei camp-meeting notturni dell’Ottocento (riguardante un po’ tutte le denominazioni religiose), grazie a ritrovi collettivi, anche di migliaia di persone, dove non erano usati innari ma s’improvvisava o s’andava a memoria, a causa sia dell’analfabetismo diffuso che per le condizioni precarie di luce dei falò e delle torce.
Il racconto prosegue nel periodo post-emancipazione con nuove raccolte di inni e canti popolari, e altri personaggi importanti come il predicatore metodista itinerante Charles A. Tindley, principale e inconsapevole fautore del gospel, maturato nei primi decenni del Novecento anche in ambito urbano attraverso le crociate evangeliste di figure come Dwight Lyman Moody, Ira David Sankey e la coppia dei bianchi Homer A. Rodeheaver e Billy Sunday, questi ultimi molto influenti sul padre del gospel, Thomas A. Dorsey, personaggio chiave nella musica del Novecento e così prolifico da portare avanti per molto tempo un alter-ego di pianista blues, Georgia Tom, per Ma Rainey, Tampa Red e altri, componendo quasi un migliaio di canzoni e influenzando generazioni di cantanti blues e rhythm and blues.
Non mancano testimonianze e racconti sulle danze e sulla musica ricreativa (pattin’ juba, canzoni per violino, gighe e canzoni “del diavolo”) e in ambito lavorativo, sul minstrelsy e le prime celebrità del teatro e del cabaret, sulle canzoni del movimento abolizionista, ma anche sulla musica da celebrazione o parata e delle forze armate.
Illuminanti alcune citazioni sulla fascinazione che la musica nera esercitò sui casuali osservatori stranieri, e la determinazione, la bellezza e la potenza immaginifica della stessa, qualità che aprirono le porte anche negli ambiti musicali fino a quel momento riservati ai bianchi.
Attenzione è rivolta alla nascita del nazionalismo musicale – l’inizio di un’autentica e riconoscibile scuola musicale americana – nel Novecento, con il contributo di grandi compositori afroamericani (tra questi, spiccano Harry T. Burleigh, studente preferito di Dvořák, ma anche Will Marion Cook e i fratelli John Rosamund e James Weldon Johnson, questi ultimi attivi soprattutto nella musica teatrale e da operetta, Clarence Cameron White, R. Nathaniel Dett, William Grant Still, fino ai compositori dell’epoca moderna, come Quincy Jones e Isaac Hayes), straordinari cantanti lirici d’opera e da concerto, magnificenti orchestre e cori, significativi ed eccellenti strumentisti e musicisti (furono tantissimi; cito solo Joseph Douglass come primo violinista afroamericano a fare tour transcontinentali) ed educatori, talenti eccezionali che assunsero importanza anche simbolica mentre, tra le prime orchestre sinfoniche, grande impatto e importanza ebbe all’inizio del Novecento la Clef Club Symphony Orchestra diretta da James Reese Europe, con 125 elementi comprendenti anche mandolini e banjo.
Molto interessanti i paragrafi sul ragtime e sulle orchestre sincopate a cavallo del nuovo secolo che annunciarono il jazz in città come New York e Chicago, mentre a New Orleans erano le bande di ottoni e le orchestre da ballo a farlo. La “sezione blues”, in quanto genere a sé, è ridotta (e alcuni stili correlati, come lo zydeco, completamente ignorati), ma l’autrice torna sul tema, anche se brevemente, in varie riprese, e non si deve affrontare il libro con l’idea di leggere nello specifico di musica blues.
A conforto dell’idea che è impossibile stabilire l’esatta origine del blues, Southern cita (dal libro di Nat Shapiro e Nat Hentoff, Hear Me Talkin’ to Ya, 1955) alcune risposte sulla questione, come quella di un vecchio violinista di New Orleans: “Il blues? Non c’è un primo blues! Il blues c’è sempre stato!”. Eubie Blake invece riferì: “Il blues a Baltimora? Ma Baltimora è il blues!”, mentre Bunk Johnson disse a un intervistatore che quando era ragazzino (anni Ottanta dell’Ottocento) non suonavano altro che blues; nello stesso periodo a New Orleans anche i venditori ambulanti lo suonavano, su strumenti giocattolo, per attirare l’attenzione dei clienti.
In effetti, ci sono brani popolari e spiritual del XIX secolo che si sarebbero chiamati blues se al tempo il termine fosse stato in uso come identificazione di genere, mentre nelle canzoni la parola era già usata come dimostrano alcune raccolte uscite nel 1911 e 1915 pescanti brani anche di qualche decennio prima: I’ve got the blues / I’m too damn mean to talk / A brown-skin woman make a bull-dog break his chain.
Nell’ultima parte ha ruolo centrale il racconto dell’Harlem Renaissance, passando anche per le produzioni teatrali più di successo, oltre alle varie fasi di sviluppo del jazz, la nascita dei race record, le conseguenze della seconda guerra, l’affermazione del blues e suoi derivati (R&B, soul, rock ‘n’ roll, e il pop dai quartetti vocali al rap), per arrivare a una panoramica fino al periodo dell’ultima edizione del volume, tra correnti nuove e di ritorno sulla scena della musica popolare come di quella colta.
Purtroppo anche in questo testo si nota qualche errore. Credo che fra tre traduttori almeno uno con qualche cognizione sulla musica americana e afroamericana sarebbe stato opportuno. Non conta neppure se alcune di queste sviste fossero, magari, nella versione originale; vanno comunque corrette.
Così ecco che qualsiasi piccolo intenditore sa che le trasmissioni del programma radiofonico King Biscuit Time provenivano da Helena, non Melena (in entrambe le volte in cui la città è citata), e che Buddy è Bolden, non Golden. Inoltre non è necessario tradurre “Queen of the Moaners”, in quanto “moaner” qui determina una tipologia di cantante texana, uno stile, mentre è un peccato che invece dove bisognerebbe farlo non lo si faccia, con il purtroppo ricorrente e assai ridicolo vezzo di non tradurre sound nel suo corrispondente suono (non c’è nessun elemento in più o significato diverso nel termine inglese), usanza ancor più imperdonabile nel linguaggio scritto. Che dire poi di novelty-songs: non sono “canzoni-novità” (e che significherebbe poi?), ma canzoni umoristiche, buffe (o insolite, stravaganti).
Infine, tra qualche errore di stampa qua e là, si legge che il “movimento a favore della fondazione di congregazioni nere indipendenti” prese piede nel “tardo Ottocento”, invece che nel tardo Settecento (tra l’altro i nomi dei secoli a volte sono in minuscolo…).
In copertina, tra immagini di musicisti simbolo di vari generi, spicca Leontyne Price, cantante lirica che mi ha fatto apprezzare l’opera Porgy & Bess, e una delle prime voci nere che ho sentito e amato.
Il libro chiude con i compositori, i cantanti e gli strumentisti di musica classica dagli anni Quaranta alla fine del Novecento, la produzione di Treemonisha del geniale Scott Joplin, il resto dell’avventura dei compositori neri a Broadway, al cinema e in televisione, e le correnti di fine secolo, del jazz, della musica accademica, del pop, del gospel, lasciando il discorso aperto e con la considerazione che «la caratteristica costante della musica nera non è stata né la protesta né l’espressione artistica, ma la comunicazione, e non si può immaginare un tempo in cui i musicisti neri non avranno nulla da dire, né agli altri né a Dio», mentre il vecchio non viene mai abbandonato del tutto riemergendo nel nuovo e rinnovando costantemente la musica nera.
Tra le tante citazioni d’epoca che avvalorano la suggestione e l’influenza della creazione musicale afroamericana trovo particolarmente significativa quella che segue, rivelante la coscienza ormai matura del fenomeno da parte degli osservatori bianchi e un aspetto profetico, perché ciò che descrive ha continuato a succedere nel tempo, anche se con modi e risultati diversi.
Chi sono i nostri veri capi? I poeti neri, certamente. Non sono forse loro a decidere le mode e a dettar legge sul gusto del pubblico? È sufficiente che uno di loro componga una nuova canzone nelle paludi della Carolina, e che quella raggiunga l’orecchio di un dilettante bianco, che viene subito trascritta, migliorata (vale a dire, quasi rovinata), stampata e diffusa così rapidamente da fermarsi solo agli estremi limiti del mondo anglosassone, forse ai confini del mondo intero. Nel frattempo, il povero autore continua a vangare, totalmente all’oscuro della sua grandezza. (3)
- Il time line, descritto da Bowdich come «sempre perfetto, e anche i bambini legati alla schiena delle madri muovono la testa e gli arti in perfetta sintonia con la musica che sta suonando».[↩]
- Missionari riferirono che gli schiavi mostravano un “piacere estatico” nel cantare i salmi e gli inni di Watts.[↩]
- J. Kinnard, Who Are Our National Poets, in Knickerbocker Magazine, 1845, n. 26; ristampa in The Black Perspective in Music, primavera 1975, n. 3, pp. 83-94, cit. pag. 85. Cit. in E. Southern, La Musica dei Neri Americani, pag. 102.[↩]
È vietata la riproduzione anche parziale di questo articolo senza autorizzazione






Un libro importantissimo che NON DEVE mancare sullo scaffale dei veri appassionati della storia (non solo musicale) del popolo AfroAmericano!!!