Allen, Ware, McKim Garrison – Slave Songs of the United States
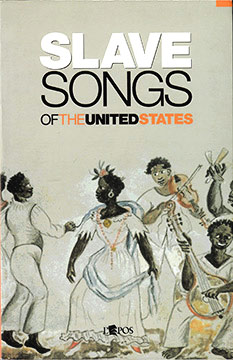
Uscita nel lontano 1867 con il titolo Slave Songs of the United States questa raccolta di canti, soprattutto spirituals, è il frutto del forte interesse e delle ricerche di tre studiosi che, nel periodo dell’emancipazione degli schiavi americani, viaggiarono nelle ex-colonie schiaviste, in particolare nelle Sea Islands, in qualità d’insegnanti di inglese: la scolarizzazione degli schiavi liberati fu forse l’unico progetto riuscito tra i diversi avviati dalla Ricostruzione riformista del temporaneo Governo del Nord.
Tra i primi (inconsapevoli) etnomusicologi, William Francis Allen, Charles Pickard Ware e Lucy McKim Garrison durante le loro missioni furono colpiti dalla musica e dai canti del popolo afroamericano e quindi dai relativi aspetti semantici, in particolare Allen, autore della stimolante introduzione originale alla raccolta, antischiavista, storico, filologo, pianista e flautista.
Lucy McKim, insegnante e pianista, scoprì i canti degli schiavi durante una missione didattica del padre, noto abolizionista, e fu forse la prima persona a trascrivere, pubblicare e descrivere delle melodie sentite nelle isole di Port Royal, note a tutt’oggi probabilmente proprio per questo, tra le quali Roll, Jordan, Roll e Poor Rosy. Charles Ware invece, studente di Harvard come Allen, e collezionista di canti raccolti durante i viaggi nelle Sea Islands, con il suo primo gruppo di reperti musicali diede il via alla pubblicazione del libro.
Slave Songs è il primo esempio, seppur limitato, di musicologia comparata (ora, etnomusicologia), uscito almeno trent’anni prima rispetto alle ricerche fondamentali di Franz Boas, il padre dell’antropologia culturale americana. Un testo importante, il più antico del genere, assolutamente privo di riferimenti precedenti e ignaro d’inaugurare una ricerca poi seguita nel corso del Novecento da innumerevoli altre.
Se da una parte Allen si ritiene fortunato d’esser venuto a contatto diretto con questa realtà espressiva, fino a quel momento estranea ai bianchi che non fossero i padroni o i pastori protestanti, e quindi d’aver assistito alle rappresentazioni sacre degli schiavi ancora radicati in comunità e poco influenzati dal mondo esterno, dall’altra si rammarica del ritardo, perché tanti canti già erano andati perduti e altri sarebbero scomparsi con lo smantellamento dei campi di lavoro e con la scolarizzazione. I tre non furono i primi ad accorgersi della particolare vena musicale degli afroamericani, infatti già nella letteratura di viaggio del Settecento e dell’Ottocento emergono commenti in tal senso, difettanti però di descrizione musicale. Ciò che premeva ad Allen e compagni era rilevare il carattere di purezza e il desiderio d’isolare quell’espressione tipicamente negra, considerata barbara, all’interno di una più generale influenza euro-americana.
Nell’analisi introduttiva di Allen, già di per sé interessante perché è uno spaccato della vita, del linguaggio, delle persone e della cultura nelle colonie, sono molto suggestive le parti riguardanti la ricerca della religione, il cosiddetto fin’ dat ting, vagare reale e allegorico per “trovare quella cosa”, e l’analisi del lessico gullah, peculiare degli abitanti delle Sea Islands, con alterazioni fonetiche e di sintassi, corruzioni e forme pleonastiche. Qualche esempio: abbreviazioni come lee’ bro’ per little brother, invenzioni come ona (tu) e il rafforzativo aw (di sicuro, proprio così), le corruzioni sh’um per see ‘em, huddy e huddy-o (per i saluti) al posto di how do?, studdy per steady, indicante un’azione continuata o abituale (He studdy ‘buse an’ cuss we, continua a tormentarci e insultarci), sic-a o sake-a come combinazione di same e like, enty per ain’t he, ma usato come “davvero?”, day-clean e sun-up al posto di day-break, chu’ per “questo” o “quello là”.
Sulle espressioni compiute, abbiamo frasi come – My back stan’ like white man, con “stan’ like” usato come “look like” (La mia schiena sembra quella di un bianco, vanteria per non avere segni di frustate), la risposta di un vecchio di Charleston alla domanda se fosse scappato da solo dalla piantagione – Me one, and God (“one” in luogo di “alone”), parti di benedizioni e preghiere – Arter we done chaw all de hard bones and swallow all de bitter pills (Ora che abbiamo masticato tutte le ossa dure e inghiottito tutte le pillole amare).
Le risposte a domande comuni tipo “come va oggi?” erano vaghe e non convenzionali, come stirrin’ (sono sveglio), spared (me la cavo), standin’ (sto in piedi), out o’ bed (sono fuori dal letto), o he feel a lee better’n he been (si sente un po’ meglio di prima). Anche i nomi propri spesso erano frutto di storpiature o di fantasia, come After-dark, perché chi lo portava era così nero che “non riesci a vederlo finché fa giorno”.
Il lato più importante è quello dei canti, la cui disamina è completata dai curatori italiani e in tutto sono più di centotrenta, suddivisi per aree geografiche. I tre autori non si limitarono a rilevare il testo, con difficoltà per l’uso massiccio del vernacolo, ma trascrissero anche la melodia e ne annotarono il tempo, pensando a un uso pratico del libro anche se, n’erano consapevoli, non era possibile annotare su carta le complesse modulazioni vocali, timbriche e ritmiche dei neri, che fossero radunati in cerimonie religiose o intenti al lavoro, così come, con stupore, le sentivano loro.
Il fatto che manchi la trascrizione armonica è forse solo un effetto dei tempi e degli interessi dei trascrittori e, non ultimo, della difficoltà, non dimostra che i canti non avessero una struttura armonica; semplicemente, forse, essendo lontana dai canoni dell’armonia occidentale, è stata elusa. Un contributo alla raccolta arriva anche dal Colonnello Higginson (1823-1911), comandante del primo reggimento formato da soli afroamericani al servizio dell’Unione, i South Carolina Volunteers. Abolizionista, pastore protestante, scrittore, collaboratore del movimento Railroad Underground, vicino alle lotte di John Brown, Higginson rimase affascinato dai canti dei suoi soldati, descritti in un altro testo mai arrivato in Italia, Army Life in a Black Regiment.
Il volume è arricchito da una consistente prefazione di Luca Cerchiari, curatore dell’opera, il quale descrive con cognizione e competenza i fattori storici, sociali, religiosi, esistenziali e narrativi degli afroamericani, per una più agevole comprensione della loro cultura e soprattutto dei contenuti del libro. Libro che in origine era essenziale, senza il senno di poi, considerando anche che era rivolto ai contemporanei americani, ai quali si voleva far notare l’espressività musicale e la significazione poetico esistenziale dei canti afroamericani, più che il rilievo storico e sociale.
Di Cerchiari particolarmente apprezzabili sono le analisi sul dualismo, sull’evangelizzazione degli schiavi, il riferimento alle teorie di J.M. Spencer, la descrizione delle cerimonie ring-shout.
Fondamentale il contributo di Roberto Leopardi che non solo traduce frasi ostiche, ma anche interpreta, assieme a Cerchiari, il senso dei versi attraverso riferimenti biblici e storici, aggiungendo note tecniche per chi volesse suonarli.
Un testo importante da leggere con attenzione, che guarda dal punto di vista storico, mistico, religioso, linguistico, che conferma la fragilità di certe divisioni care all’antropologia, come quella tra sacro e profano, e va a coprire uno dei tanti buchi dell’editoria musicologica italiana.
Non ci si deve lasciare influenzare dalla difficoltà di adattare le parole alla melodia. I negri mantengono un perfetto senso del tempo, e non si preoccupano di eventuali ostacoli nel testo. Essi riescono a far combaciare il più ostinato verso biblico o frammento di inno con qualunque melodia possa loro piacere, anche lanciandosi eroicamente alla testa di una colonna di giambi attraverso una melodia trocaica. – W.F. Allen, 1867
È vietata la riproduzione anche parziale di questo articolo senza autorizzazione





